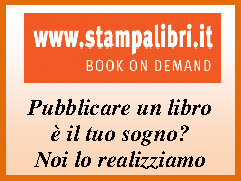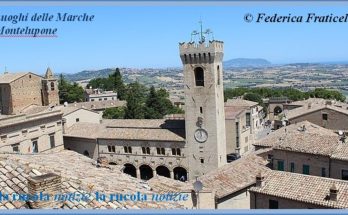Siamo in periodo di festività e di regali e mi pervade il buonismo festaiolo. Per questo mi sento in dovere di fare idealmente un regalo utile ad alcuni relatori al Congresso del Centro Studi Storici Maceratesi 2023 sul tema “Il Maceratese e Le Marche Centro Meridionali tra Impero e Papato (Sec X-XII)”.
Mi corre l’obbligo dopo aver letto gli atti pubblicati lo scorso novembre a cura dello stesso Centro Studi, che, però, ne prende le distanze con un distinguo scritto piccolo piccolo: “Gli scritti firmati rispecchiano le opinioni degli autori. La loro pubblicazione non implica adesione del Centro Studi Storici Maceratesi alle tesi sostenute” (prima pagina senza numero dopo pagina 293). Ho imparato dal presidente di questo Centro Studi che “La storia si fa con i documenti e non con la fantasia” e anche che essa è materia scientifica, pertanto un saggio di scienza storica non dovrebbe essere opinabile come non è opinabile il dato scientifico che il sole non può illuminare la notte oppure che, come scoperse un tal Junkers, a 50 gradi Centigradi l’acqua è calda.
Forse gli storici sono più avanti di me nella scientificità e hanno gran familiarità con la teoria Einsteiniana della Relatività Speciale, perciò possono aderire o meno a queste tesi entrando in una dimensione di relatività storica tutta loro. Ciò a parte, dopo quello di Florian Hartmann ho letto il saggio del professor Francesco Pirani che qui affronto per primo in virtù del fatto che l’autore mi fu presentato da comuni amici quando era agli inizi della sua carriera di storico. Il saggio esposto a Montecò s’intitola “Alle origini della Marca di Ancona Circoscrizioni e poteri pubblici nel XI secolo”. Il cui incipit recita: Sullo scorcio del secolo XI si produsse in area medio adriatica una netta ridefinizione dei quadri circoscrizionali. Nel 1094 Enrico IV istituì la Marca di Ancona… Lo scopo dichiarato del saggio è definire la consistenza territoriale di questa “Marca” ma nella pagina successiva l’autore anticipa le conclusioni della ricerca scrivendo: “Concluderò dunque in modo tranchant ricorrendo a un’espressione mutuata dalle categorie filosofiche: della Marca di Fermo e di quella di Camerino nuda nomina tenemus.” Che interpreto come “non ne so un bel nulla”.
Seguono una dozzina di pagine nelle quali sono citati una gran quantità di documenti e di nomi di personaggi politici come condimento di una fantasmagorica “distrettuazione” del territorio; pagine nelle quali, non essendo io un professionista della storia, avrei gradito leggere una definizione del significato di “distretto” applicabile all’Età di mezzo e magari un paio di parole esplicative dei criteri metodologici con cui è stata condotta la ricerca. Perciò, basandomi su una documentazione esterna alla “distrettuazione” del comprensorio anconetano, pensando alla trentina di differenti forme di prelievo fiscale già in vigore ai tempi di Carlomagno (pare che la maggior parte le abbia inventate Pippì lu Ciucu suo padre), sono passato a considerare la questione dell’attribuzione differenziata del prelievo fiscale caratteristica del Medio Evo.
A quei tempi il diritto a chiedere tasse era rimescolato sui territori e fra gli aventi causa con una certa frequenza, più o meno come si mescolano e si danno le carte giocando a scopa. Poi, sulle tracce delle continue dispute degli Anconetani con i Veneziani per i traffici nell’Adriatico, ho immaginato che il negazionismo storico (di cui tratto nei miei libri) non gradisse descrivere la realtà sociopolitica di Ancona come la quinta Repubblica Marinara. Accostando le due cose ai documenti citati nel saggio, potrebbe apparire la configurazione sociale della Città e del suo porto, piuttosto che l’astrazione dei distretti della Marca, e le conclusioni essere un poco più consistenti che la dotta citazione latina resa celebre dal romanzo di un suo più famoso collega. Per il nostro storico maceratese chiederei alla Befana di portargli in dono l’opera del grande Marc Bloch dal titolo “La società feudale”.
Passando oltre, leggo che a sostenere l’ennesimo tentativo di scalzare la tesi di don Giovanni da San Claudio (ndr: titolo onorifico essendo il prof nativo di Capracotta), è ritornata a farci visita la gentil signora Ildegard Sahler, nota qui da noi piuttosto che altrove per aver messo insieme un ponderoso quanto costoso volume tradotto anche in italiano, in cui vede chiese Duecentesche di forma cubica nei palazzi signorili del Carlone e dei suoi fideles marchigiani. Devo perciò tornare sull’argomento di come i filologi germanici, per dare un senso e un nome all’unico monumento medievale superstite di Aachen (del XII secolo), condizionati dal fatto che già molto prima i Francesi, per via dell’unica citazione ne La chanson de Roland, riferita a dove Carlomagno stesse di casa, recita “ad Ais a sa capele”, ma i Francesi, non sapendo dove fosse questa “Ais” perché nel Nord Europa un’Aquis Grani non c’era e non c’è mai stata (sono costretto a ripeterlo alla nausea) usarono il contenuto di questo verso per dare un nome alla lontana e sconosciuta località della sede carolingia che divenne per loro Aix la Chapelle, toponimo che gli storici tedeschi si sono trovato pronto per l’uso sulla scrivania.
Ai bagni di Aachen c’era solo l’edificio ottagonale dell’Età del Barbarossa e inventarono che quello fosse la Cappella Palatina, anche se nessun documento autentico medievale ha mai parlato di Capellam Palatii, ma visto che Bad Aachen era una città recintata e non una ridente zona pianeggiante nella valle del Chienti dove Carlone poteva starci largo e comodo, dovettero inventarsi che la Cappella richiamata nella Chanson era a fianco del Palazzo regio, da qui la “Pfalzkapelle” (cappella del palazzo reale) titolo che ha condizionato anche don Carnevale quando studiò da privatista sui libri di storia tedeschi, pertanto “Cappella” rimane imperterrita come etichetta incollata a San Claudio. Chiose a parte, non posso commentare seriamente un saggio su architetture che dimostra una certa confusione anche solo nella terminologia usata per identificare gli edifici. L’architettura, senza presunzione alcuna, è prima di tutto un fatto strutturale e se la si analizza ci vorrebbe la dovuta competenza, come se si vuol scrivere di patologie mediche non si può usare mal di pancia o colpo della strega.
A parte il fatto che non ha senso alcuno indicare affinità tipologiche (typologische Gemeinsamkeiten) fra un edificio residenziale a due piani marchigiano e una chiesa tedesca costruita sul culmine roccioso di un piccolo poggio. Prima di trattare le Doppelkapelle, occorre considerare che nel caso specifico tedesco, dove non c’era spazio per fare una chiesa con una unica navata lunga (Kirchenschiff) sufficiente a separare lo spazio per i contadini da quello dei loro signori feudali la necessaria separazione venne attuata facendo due piani sovrapposti, comunicanti al centro, questa Doppelkapelle (Cappella doppia) non ha nulla, sia compositivamente (architektonische Komposition) sia strutturalmente (Tragwerk) a che vedere con San Claudio. Osservo che anche e solo dal punto di vista della stesura del testo (inventio dispositio elocutio) , mettere sempre il nome in tedesco dell’edificio italiano (Italienisches Gebäude) ha poco senso perché la terminologia tedesca non è un riferimento all’origine costruttiva (il movimento di Walter Gropius è di là a venire) e noi non abbiamo bisogno di compulsare testi d’architettura antica in tedesco perché bastano e avanzano le opere dell’Alberti e Rivoira, soprattutto quando trattano cose di casa nostra che nessuno è mai andato a copiare in Germania.
Poi, sarebbe auspicabile una certa coerenza quando si definisce un soggetto tipologico nostrano, dando alle parole il loro significato preciso. Se di Pfalzkapelle si vuole parlare (cioè Cappella Palatina, ergo cappella del palazzo), non si può scindere la Cappella dal Palazzo (regio) e pertanto il binomio non è replicabile dappertutto dove ci sia solo l’edificio cubico, come se, dove abbiamo quella tipologia definita “Chiese a croce greca inscritta”, ed ora “a quattro sostegni” secondo la scrittrice, queste siano anche e allegramente Cappelle Palatine senza il relativo palazzo reale (Pfalz). Ė superfluo qui spiegare perché solo San Claudio fra queste sia a due piani, ma mi fa sorridere leggere che il piano alto fosse la residenza del vescovo di Fermo, perché non posso pensarlo un eschimese che d’inverno fa a meno dei camini e neppure indago su quale ditta di catering lo servisse, mancando ogni traccia di forno da cucina e di altri “servizi” necessari in una residenza. Forse dormiva su un poco di paglia per terra visto che dalle strettissime scale a chiocciola e dall’assenza di fenestrature sufficientemente ampie al piano superiore, non si sa come si siano potuti infilare nel suo appartamento cose come un letto, un canterano, un tavolo, quattro sedie e un paio di poltrone. Cose superflue se il vescovo ci alloggia in astratto solo per soddisfare la fantasia creativa degli autori (ndr: e un cèsso non ce lo mettiamo? Ah, no… probabilmente c’era un canneto da qualche parte lì fuori).
Per analizzare una composizione architettonica (ovvero le volumetrie funzionali alla destinazione d’uso e il contesto strutturale che le materializza) occorre innanzitutto avere una minima conoscenza della materia, non basta guardare una planimetria su un libro d’arte. Ma se leggo alcuni passaggi, sinceramente non mi ci raccapezzo, come ad esempio :”Dopo l’anno Mille la chiesa a sala (hallenkirche) con quattro sostegni si riscontra come cappella palatina specie nell’Italia settentrionale e centrale, ma l’edificio allo stesso tempo può assumere la funzione di cripta, battistero o pieve”. In tutta sincerità non so come commentare simili asserzioni, dove si mescolano denominazioni funzionali diversissime con l’incomprensibile creazione di una tipologia “a quattro sostegni” che assume il nome di Cappella Palatina che nella nostra lingua non ha un significato compositivostrutturale ma solo funzionale, poi gli si fa fare di tutto e andare dappertutto nell’Italia, infine diventa addirittura Cripta. Dicesi “cripta” l’ambiente generalmente ipogeo o seminterrato che per la sua collocazione è “nascosto” (κρυπτός) e da ciò il nome raffinato e grecizzante. Altrettanto astratto è pensare che un tale edificio fosse esclusivamente un battistero, che solo in casi eccezionali come a Pisa, è un edificio a sé stante. Il colpo da maestro (Meisterleistung) in questa creatività tipologica è “pieve”: la pieve è stata una circoscrizione amministrativa di anime (plebs) dei territori generalmente agricoli gestiti dai primi religiosi Cristiani, al pari di nomi come parrocchia o diocesi; solo in casi rarissimi, ma senza alcuna tipologia edilizia specifica, il lemma pieve ha anche identificato l’edificio di culto in cui si riuniva la comunità “pievana”, come è stato per la chiesa sede della cattedra episcopale che dappertutto si chiama Cattedrale.
Poi si stravolge anche il diritto canonico scrivendo che San Claudio era cappella di palazzo e nel contempo una “pieve privata” del vescovo (pag 190). Non capisco come possa essere determinante in una disamina funzionale il tipo strutturale “a quattro sostegni” che non qualifica nulla perché semplice conseguenza della volontà di fare aule più larghe di quattro metri, a prescindere dalla destinazione d’uso. Parlando di una chiesa a tre navate con arcate su pilastri compositi come San Pietro in Vaticano, dovremmo vederci una tipologia “a sei sostegni doppi”. Allo stesso modo non colgo la ragione di vedere una chiesa già nata come tale in quegli edifici “di rappresentanza” che erano in realtà un tipo particolare di luoghi del potere laico, senza che ci sia il supporto di notizie di una qualche confessione religiosa che, solo qui da noi, faceva liturgie in chiese cubiche anziché “a nave” come dappertutto. Se ci si arma di una improvvisata competenza architettonica per venire in Italia a scrivere un solo libro su San Claudio e gli altri palazzi dei Domini Loci Franchi nelle Marche, per contestare don Carnevale, è difficile che la cosa funzioni semplicemente accostando fra loro planimetrie di edifici con absidi semicircolari, il risultato non può essere diverso da quello che chiunque può leggere, e perciò capisco il Centro Studi che ha preso diplomaticamente le distanze dai contenuti degli interventi.
A questo punto mi punge vaghezza di capire per quale ragione si sia fatta venire dalla lontana Germania questa “storica dell’architettura” alla quale posso consigliare di farsi spiegare qualcosa da un Bauingenieur (Ingegnere edile) e poi chiederò alla Vecchia di metterle nella calza il “Dictionnaire raisonné de l’architecture francaise du XI au XVI siècle” di tal Viollet-le-Duc, ricco di illustrazioni come il saggio in questione. Mi proponevo di fare qualche commento anche sul lavoro del critico d’arte dottor Furio Cappelli, ma desisto perché non riesco a capire come leggerlo e dove colga i legami fra San Claudio e le porte romane, la mia fantasia non riesce a volare così alto, ma mi sento di chiedere alla Befana di portargli “Alice nel paese delle meraviglie”. Amen.
Medardo Arduino

25 marzo 2025