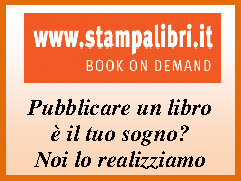Stamane sono stato svegliato da un gran batter d’ali davanti a casa e dalla finestra ho visto Dumbo che faceva evoluzioni acrobatiche: tonneau, looping d’ala e passaggi in volo rovescio emettendo da sotto il codino una scia di fumo bianco. Non mi sono affatto stupito perché iersera mi hanno segnalato su Youtube una contestazione multipla di una foto che doveva rappresentare le “cisterne romane di Fermo”.
A riguardo di questa per me imbarazzante (anche per molti visitatori) definizione dell’architettura romana interrata alla base delle mura di cinta della Firmum romana, continuo a non capire perché come oggi, nel mondo dell’informazione multimediale world wide, si continui a mantenere viva cocciutamente la definizione d’uso maturata in età barocca relativa a un’opera edile che di sicuro cisterna non poteva assolutamente essere. Perché non è proprio possibile che sia nato come cisterna l’edificio interrato di Fermo ancora venduto come tale in omaggio a non so cosa.
Quella di Fermo non è “Cisterna” per quanto segue
Primo: le cisterne e i serbatoi di accumulo dell’acqua da distribuire alle utenze civiche (prima dell’invenzione dell’autoclave) sono da quando esistono e dappertutto poste nel punto più in alto del sito da servire, perché l’acqua scende naturalmente e non sale (anche qui a Treia era così e il serbatoio non si è spostato). Invece a Fermo sarebbe stato il contrario: le cisterne sono nel punto più basso e, allora , in pratica, come facevano i cittadini fermani ad approvvigionarsi: andavano a prenderla con i secchi? Solo un amministratore romano incompetente e prepotente avrebbe imposto di fare una cisterna al contrario della logica della funzione.
Secondo: le cisterne raccolgono l’acqua piovana e lì dove è messa se fosse stata una cisterna avrebbe raccolto l’acqua di deflusso dalle strade (e quindi dal sistema fognante) della città e non è il caso che ne spieghi anche le conseguenze.
Terzo: le cisterne romane, dovendo contenere acqua che è il miglior solvente naturale, erano tutte e dico e ripeto tutte, con i muri completamente impermeabilizzati fin sopra il livello di massimo utilizzo per evitare che l’acqua sciogliesse la malta fra i mattoni delle pareti. Usavano, per chi non lo conosce, un impasto “grasso” di macinato fine e “pozzolana” o calce idraulica, assolutamente impermeabile detto opus signinum, poi detto anche cocciopesto. Per avere un’idea più precisa di come fosse una vera cisterna di accumulo basta andare in località Fontebella e chiedere al proprietario di farti visitare la cisterna romana a fianco della sua villa. Cito quella perché è vicina a Fermo e della stessa epoca della non cisterna fermana, altrimenti basta andare su internet e digitare cisterne romane per vederne a iosa, tutte egualmente ricoperte di “opus signinum” fino all’imposta delle volte. L’edificio di Fermo, costituito da tre vani giustapposti voltati a botte e tramezzati con otto setti trasversi con una grande apertura centrale, in modo da avere trenta ambienti separati, non ha le caratteristiche utili a far defluire regolarmente l’ipotetico flusso continuo del liquido, anzi il contrario. Strutture inutili quanto costose.
Quarto: le cisterne hanno, detto nel gergo degli idraulici, i cosiddetti “sfiori” ovvero quelle aperture poste in corrispondenza del livello di massimo riempimento che servivano a evitare che l’acqua che è incomprimibile, quando avesse saturato un volume senza sfioratori di sicurezza, avrebbe fatto esplodere la cisterna. Generalmente poco sotto agli sfiori si notano sulle pareti le tracce scure lasciate dalle particelle organiche che galleggiavano sull’acqua. Questi “sfiori” lì a Fermo non ci sono, ma non ci sono nemmeno le bocche di prelievo con paratia, poste a varie altezze nel muro di fondo, caratteristiche delle vasche di accumulo degli acquedotti romani. Tali acquedotti d’età classica (quei lunghissimi ponti a più piani di arcate tonde) alimentavano le città con condotte d’acqua “a pelo libero” di cui, ovviamente, non c’è traccia intorno alle “cisterne” perciò l’acqua “incisternata” non potendo andare da nessuna parte non se la sarebbe presa nessuno. Le Cisterne sarebbero rimaste perfettamente integre ma senza alcuna traccia dei sistemi per l’utilizzo. Guardacaso non era necessario costruire una monumentale “cisterna” oltre a quella più logica e più piccola vicino al Duomo quindi troppo in alto per intercettare le falde sotterranee, perché Fermo è l’unica collina dei dintorni che abbia una falda acquifera che alimenta molti pozzi e per questo è stata abitata dalla preistoria ed è diventata in età classica una “Città Caserma” in cui Gneo Pompeo manteneva alcune legioni. (cfr. Via dei Legionari).
Quinto: l’edificio fermano è impermeabilizzato solo per tutto il pavimento e per circa una settantina di centimetri alla base dei muri interni, quindi l’acqua si sarebbe potuta accumulare fino a circa mezzo metro d’altezza in un ambiente con un volume costruito, ma inutilizzato, dieci volte tanto, perciò complessivamente in massima parte inutilizzato a dimostrare che i dominatori del mondo conosciuto, tecnicamente eccellenti e razionali, quelli che hanno costruito il Pantheon e il Colosseo, oltre ad acquedotti che ancora oggi stupiscono per la perfezione e la regolarità della pendenza (intorno all’1,5% costante anche per sessanta chilometri) questi efficienti ingegneri a Fermo avrebbero costruito e interrato un cisternone utilizzato per meno del 10% della sua volumetria costruita, dimostrando di avere un mucchio di soldi da buttare via e di non aver mai visto un’altra vera cisterna romana.
Adesso chiediamoci da dove viene la stramba idea delle cisterne e poi la mia opinione sul monumento. Andando a ricercare l’origine dei vocaboli spregiativi di persone, quali idiota, burino , buzzurro, villano ed altri relativi in origine alle attività degli agricoltori, ho verificato che sono nati dall’atteggiamento di quei “figli di papà” che nell’Italia barocca erano appunto i figli dei ricchi nobili proprietari terrieri, che facevano sì una dozzina di figli, ma lasciavano la proprietà massimo a due, i più intelligenti e capaci. Gli altri che si ritenevano una categoria superiore ai contadini illetterati che disprezzavano, erano avviati alla carriera monastica o militare o all’insegnamento: era facile un tempo e con un libro di testo fra le mani, leggerlo e poi dire “studiate da pag 21 a pag 43 che poi vi interrogo” e fare il professore. È stato uno di questi, forse nel Settecento, quando Daguerre doveva ancora nascere e sui libri c’erano solo litografie di disegni, ad aver visto l’illustrazione di una cisterna romana (vuoi Ponza, Latina o altre) nella quale né il colore né la definizione dell’immagine poteva evidenziare la natura del rivestimento delle pareti, perciò detto da una persona così importante per nascita e non contestabile per il potere intrinseco alla sua funzione, si cristallizzò il nome di “cisterne” dato ad un mattatoio con deposito di carni trattate, ad uso delle legioni pompeiane. Nessuno poi ha osato contraddire e oggi le guide si sforzano di dare spiegazioni che non commento, ma che fanno rivoltare Torricelli nella tomba.
Sì, quello era un mattatoio, lo dimostra il fatto che solo il pavimento era in origine impermeabilizzato e con pendenza in diagonale pressappoco dell’uno e mezzo per cento (difficilissimo da ottenere in 30 ambienti contigui, ma necessario se devo continuamente igienizzarlo col lavaggio ) per l’igienizzazione con l’acqua i muri sono stati impermeabilizzati solo dove serviva ovvero quelli controterra dove erano le aperture di aereazione (inutili se non dannose in una cisterna) mentre per i diaframmi l’impermeabilizzazione è solo alta per una settantina di centimetri, raccordata al pavimento con un arco di cerchio come è ancora oggi prescritto negli ospedali come requisito per l’igienizzazione. Nelle vere cisterne il punto delicato di unione del pavimento alla parete (contro i trafilamenti e le muffe in caso di crepe ) era protetto da uno zoccolino a sezione quadrata di circa otto centimetri di spessore. Completa la destinazione d’uso come mattatoio di bovini il fatto che in una delle sale presso l’entrata ci sia una canaletta circonferenziale a sezione circolare di circa una quindicina di centimetri di larghezza che gira tutt’intorno sul bordo del pavimento (oggi intasata di mattoni perché nessuno dei visitatori ci si inciampi), che scarica in contropendenza a quella del pavimento: lì erano sgozzati i bovini ed il sangue non raccolto scolava via dalla parte opposta alla pendenza (i mattatoi di paese una volta erano tutti così).
Siamo al solito assurdo aspetto dell’intangibilità degli ipse dixit, anche di quelli ridicoli. Io mi sgolo a ripetere che tutto questo è da rivedere, soprattutto se lo si insegna ai giovani come “eredità culturale”. Se fossero davvero cisterne quelle di Fermo ci direbbero che gli antichi romani dominatori del mondo (perchè detentori del sapere tecnologico e logistico e non certo per volontà degli dei) a Fermo hanno scialacquato un’enormità di soldi per fare un ambiente artificialmente ipogeo per avere una temperatura costante di 14 gradi (il fresco cantina) particolarmente adatto a conservare mezzene affumicate, cosciotti salati ed insaccati che dovevano rifornire le salmerie delle legioni quando arrivava il “pronti a muovere!”, e invece no, questi efficienti amministratori pubblici hanno voluto utilizzarlo come una cisterna anche se era alla base delle mura e non in sommità, perdipiù diaframmata in 30 inutili ambienti se non servivano a separare i prodotti conservati ed anche utilizzata a meno del 10% del suo volume e soprattutto per raccogliere acqua scolata dalle strade in una città caserma piena di pozzi di fresca acqua sorgiva. Morale della favola: dopo aver visitato le “Cisterne”… venite pure a vedere Dumbo che continua a fare acrobazie davanti alla mia finestra.
Medardo Arduino
4 marzo 2025