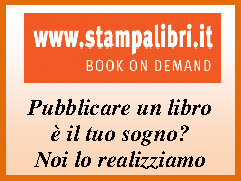Grazie all’esperienza di un agronomo ottuagenario possiamo dare uno sguardo all’agricoltura marchigiana negli ultimi settant’anni, durante i quali ha subito varie crisi complesse e spesso sovrapposte. Il sanginesino che ci guida ha operato in diversi settori: agricoltura, politica locale e assicurazioni. Scopriremo qualche curiosità e, purtroppo, anche qualche occasione persa.
Vittorio Giorgi ha iniziato la sua attività professionale nel 1953 come perito agrario, libero professionista; poi ha conseguito la laurea nell’Università degli Studi di Perugia. Negli anni Sessanta è stato insegnante supplente annuale presso le scuole di avviamento professionali statali agrarie di Caldarola e Pieve Torina: erano frequentatissime, poi cambiarono nome in Scuola Media. Una volta diplomato partecipò a cinque concorsi statali del Ministero Agricoltura e Foreste indetti per riorganizzare gli uffici periferici statali (ex Ispettorati Agrari). Superò tutte le prove scritte e orali e scelse quello riservato a tecnico del nord Italia per assistenza tecnica agli agricoltori, con campi dimostrativi, sperimentali e orientativi di nuove e vecchie colture. Lo scopo era di formare e aggiornare gli agricoltori professionalmente e culturalmente, indirizzandoli bene per ottenere dei finanziamenti statali, regionali ed europei. Le aziende agricole, all’epoca dette anche piccole proprietà contadine, potevano accedere a contributi e mutui a lunga scadenza e a tasso agevolato. Fu assegnato al compartimento regionale della Lombardia in provincia di Pavia. Nel 1966 fu mandato a Firenze e Provincia per collaborare con il Ministero dell’Agricoltura a rilevare i danni provocati al settore agricolo dalla disastrosa alluvione del 4 novembre 1966, dovuta all’esondazione del fiume Arno. È stato tecnico responsabile delle agenzie di vendita del centro Italia per la Sementi Sgaravatti Spa di Padova, produttrice di sementi a livello europeo di piante porta-semi orticole e da fiore. Si era scoperto che le Marche era una regione particolarmente vocata – tra le le migliori d’Europa – alla coltivazione di piante porta-semi. Purtroppo quella bella realtà aziendale chiuse. Rientrato nelle Marche, nel 1966 divenne responsabile dell’ufficio agricolo di zona a San Ginesio. Dopo il pensionamento, una notevole gratificazione la ebbe con l’incarico di responsabile rilievi danni ai vigneti delle Regioni Marche, Umbria e Toscana per i danni causati dalla grandine e da varie calamità naturali: all’epoca divenne uno dei pochi esperti formati nella materia. Eseguì sopralluoghi e ispezionò migliaia di vigneti, conoscendo tutte le varietà e le peculiarità di uve da vino e da tavola. Possiede da sempre un vigneto familiare a carattere sperimentale con una dozzina di varietà di uve da vino; la vite è sempre stata la sua passione. Il dottor Vittorio Giorgi è attualmente presidente del Consorzio di Tutela della mela rosa ed ecotipi della mela in genere.

Perché andò in crisi la mezzadria? – “La mezzadria andò in crisi perché lavorare nei settori industriali e artigianali, che richiedevano tanta manodopera, era più redditizio rispetto al settore agricolo. I giovani agricoltori che si dedicavano a qualche coltura arborea ed erbacea avevano dei lunghi periodi improduttivi, durante i quali non avevano una pronta disponibilità finanziaria”.
Come mai le cooperative nate nelle Marche non hanno avuto successo come in altre Regioni? – “Le cooperative agricole nelle Marche non hanno funzionato bene per vari motivi, tra cui l’assegnazione nepotista di posti di lavoro. Poi per scarsa organizzazione, competenze specifiche e vocazione all’imprenditorialità. I coltivatori del nord Italia erano disposti a fare sacrifici e attendere la vendita dei loro prodotti per spuntare ricavi migliori”.
Altre problematiche complicate? – “Dopo la fine della mezzadria, alcune aziende agricole furono gestite dai contoterzisti che disponevano delle idonee attrezzature meccaniche. Costoro si sono dedicati a colture estensive che richiedevano meno manodopera, impoverendo e depauperando il suolo fertile. Non applicavano la rotazione agraria e ciò ha portato alla desertificazione della flora batterica nel suolo agrario. Nelle Marche c’è stato solo un parziale un ricambio generazionale; spesso gli agricoltori hanno svenduto i loro prodotti, senza aspettare con pazienza di ricavare prezzi migliori. Altra causa della crisi agricola regionale sono gli attacchi massicci sia animali che vegetali alle piante e, per scarsa preparazione, non è stato possibile intervenire tempestivamente. Due esempi di queste crisi improvvise e inaspettate sono le invasioni delle cavallette dei frutteti (Calliptamus italicus) nell’estate 2023 e della mosca asiatica (mosca orientale della frutta Bactrocera dorsalis) nella stagione calda successiva. Nonché i danni della siccità, causati da quelli che oggi chiamiamo cambiamenti climatici. Gli agricoltori avevano necessità di una maggiore assistenza tecnica divulgativa e informativa, ma dove ce n’era più bisogno, nelle zone disagiate di alta collina e montagna, venne a mancare, a partire dal 1995, per la chiusura di molti uffici agricoli periferici. Le varie crisi sono state aggravate anche dalle importazioni di prodotti a basso costo provenienti da nazioni dove era (ed è) ancora possibile usare alcuni antiparassitari, anticrittogamici e diserbanti proibiti in Italia, e anche dall’importazione di grano dai Paesi dell’est Europa. È necessario un maggiore e capillare controllo delle produzioni agricole che vengono importate da fuori dell’Unione Europea. Potrebbero passare prodotti agricoli non del tutto in regola dal punto di vista sanitario”.
Eno Santecchia
4 marzo 2025