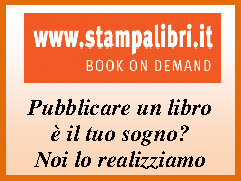Le condizioni materiali di gioco e di lavoro di una volta, soprattutto in campagna, esponevano adulti e bambini al contatto con l’acqua e superfici fredde pure d’inverno: mi ricordo che noi bambini, subito dopo i giochi con la terra oppure dopo il ritorno da scuola con la cartella in mano, correvamo per scaldarci intorno al fuoco, quasi sempre acceso in casa, o, all’arrivo a scuola, ci ammassavamo intorno alla stufa di terracotta. Lo stesso facevano gli adulti dopo aver raccolto rape o cavolfiori e dopo qualsiasi altro lavoro nei campi, dopo un viaggio in bici o in moto.
Di conseguenza, a causa degli sbalzi di temperatura, per tutto l’inverno avevamo i geloni! Cominciavano con bruciore e prurito sulle mani, a volte pure sui piedi (protetti solo dagli zoccoli fatti in casa dai genitori), sulle orecchie e sul naso: il fastidio ci spingeva a grattare o strofinare la parte gonfia e arrossata e così si passava alle vesciche e alle ferite con le conseguenti infezioni; solo allora provvedevamo a fasciare la parte quando, invece, sarebbe stato utile coprirsi prima!
L’inverno in campagna era ambivalente: intanto c’era il problema della scarsa durata del giorno e mia nonna ripeteva “spegnete la luce; studiate quando c’è la luce del sole!”; inoltre, come le piante e gli animali, anche gli uomini si riposavano nella brutta stagione; svernare, passare l’inverno, era l’obiettivo più difficile per i malati e non solo. Siccome lavorare e mangiare erano inscindibilmente connessi (chi non lavora non mangia, si diceva), d’inverno si mangiava anche poco: polenta a colazione, erba cotta a cena (si chiamava “la cucina” quando era mescolata alle patate) e, a pranzo, quando andava bene, legumi, tagliolini pelosi (cioè senza uovo) oppure solamente un pezzo di pane con qualche noce, mandorla o oliva scaldata sotto la cenere. Per compensare la scarsa alimentazione, in particolare dei bambini, quando il medico accertava la denutrizione si somministrava il famoso olio di fegato di merluzzo (come dimenticare la sua puzza di pesce fradicio?!) o il più gradevole tuorlo d’uovo sbattuto con lo zucchero.
Va aggiunto che, nonostante i rigidi e prolungati inverni di una volta, da casa ogni tanto si doveva pur uscire. Considerando che il bagno era fuori casa e allora, almeno per andare al gabinetto, bisognava vestirsi! Bisognava anche uscire per rifornirsi d’acqua potabile, che non arrivava dentro casa: la mia famiglia come riserva d’acqua da bere usava un serbatoio d’aereo, un residuato bellico bonificato e montato su un carro. Anche l’abbigliamento era alquanto approssimativo: il vestito di tutti i giorni, era per lo più fatto in casa, tessuto nel telaio di casa, tagliato e rattoppato in casa, mentre i vestiti delle occasioni come le scarpe da cerimonia si prendevano in prestito e passavano da un bambino all’altro, i cappotti e le camicie si rigiravano.
In queste condizioni le malattie mietevano vittime e ogni raffreddore poteva trasformarsi in bronchite (che si curava in casa con “l’impiastro”, un impacco bollente sul petto nudo) e la polmonite cronica poteva diventare tubercolosi; la TBC era una minaccia sempre incombente nonostante fosse oggetto di campagne di prevenzione a scuola e non solo: la TBC era entrata anche nel linguaggio comune con la maledizione più grave (il famoso “ti prenda uno sbocco di sangue”!). Invero c’erano altri incubi sanitari come la poliomelite (“i fantioli”) che, in assenza di vaccino -creato da Sabin solo nel 1957-, continuava a far vittime e a lasciare invalidità, creando i cosiddetti “infelici”.
La fatica del vivere quotidiano attivava spontaneamente anche il suo antidoto, la solidarietà tra parenti e vicini, unica risorsa a disposizione: mio padre andava a far le iniezioni (“le punture”) a casa di tutti i vicini malati, con tutti i tempi; ci prestavamo gli attrezzi e il pane, si condivideva l’eccezionale abbondanza di carne quando si macellava in casa il maiale. Considerate queste risorse, la comunità di vicinato poteva rimanere autosufficiente anche nei casi di “nevone”, quando si restava isolati per settimane o magari per un mese. Per mangiare ci si doveva arrangiare: a notte inoltrata ogni tanto passava una squadra di “uccellatori” che addossavano ai pagliai grandi reti montate su lunghi pali per catturare gli uccellini sorpresi nel sonno. Anche dentro la stessa casa colonica si trovavano riserve per l’autosufficienza prolungata in inverno: il pane e la “crescia” si impastavano nella madia e si cuocevano in casa, il vino s’attingeva dalle botti in cantina e il maiale assicurava il companatico; per passare il tempo i padri costruivano con le proprie mani i giocattoli per i figli (un triciclo di legno fatto da mio padre nell’inverno del 1950 è ancora usato dai miei nipoti, terza generazione di utenti e mio zio da un mezzo serbatoio di un altro aereo da guerra caduto ha ricavato un’auto da corsa a pedali sagomata come il bolide di Fangio!).
La famiglia patriarcale assicurava anche la socialità per non annoiarsi; dopo cena per una mezz’ora si recitava il rosario, guidato dal capofamiglia: mio nonno, per non addormentarsi passeggiava per l’ampia cucina e noi nipotini dietro a lui, aspettando le sue fermate improvvise per gli auspicati “tamponamenti” che ci divertivano tanto; in verità lui si fermava quando gli veniva in mente una faccenda e allora “Maria, -gridava, rivolgendosi alla moglie- hai chiuso i polli? Hai dato da mangiare ai cani?” Il tempo libero dopo il rosario era dedicato dalle donne a far la maglia intorno al camino e, se qualcuno s’addormentava, a svegliarlo ci pensava il nonno con una palettata di cenere furtivamente accostata al naso in aspirazione del malcapitato.
Enzo Monsù
18 febbraio 2025